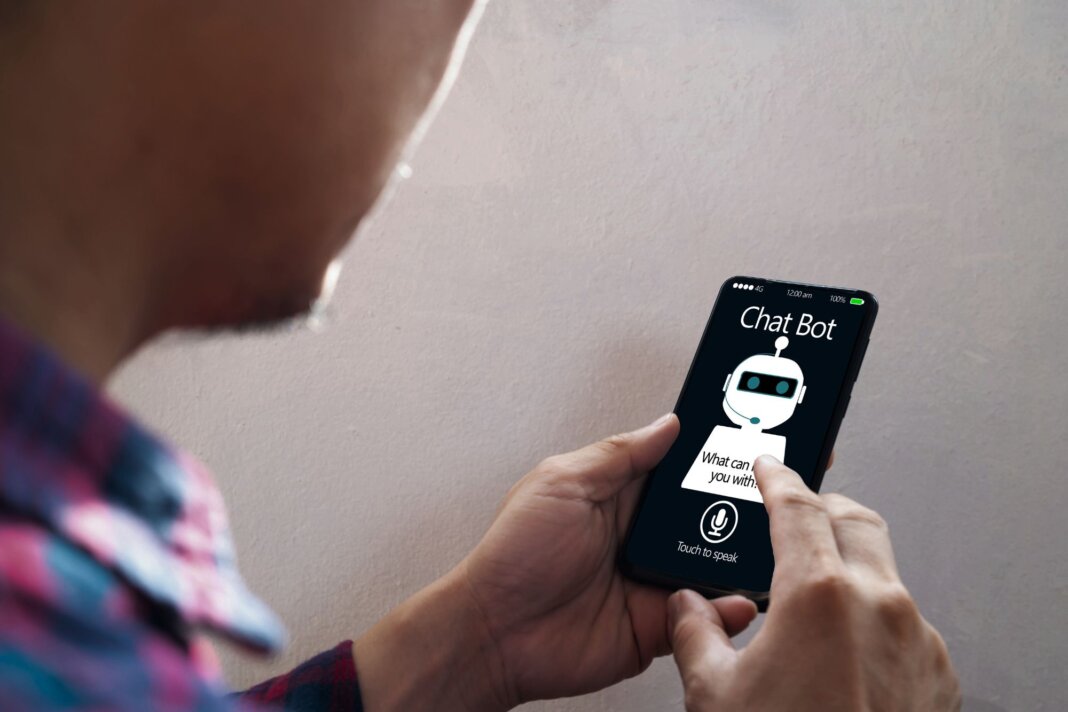Il 55% dei ragazzi italiani passa più di tre ore al giorno online, uno su quattro incontra persone conosciute solo in rete, e quasi un quarto ha assistito o subito episodi di cyberbullismo. Uno su due utilizza regolarmente l’intelligenza artificiale, ma soltanto uno su cinque ha ricevuto una formazione adeguata per comprenderne rischi e limiti.
Sono i dati del Rapporto Moige–Istituto Piepoli 2025, condotto su 1.546 studenti tra gli 11 e i 18 anni. Un’indagine che non racconta semplicemente abitudini digitali, ma una mutazione antropologica: l’idea stessa di “essere” è ormai intrecciata all’essere connessi.
Dietro le cifre, emerge una nuova forma di vulnerabilità: la dipendenza algoritmica, che non nasce dal bisogno di informarsi o comunicare, ma da un continuo scambio dopaminico tra attenzione, approvazione e visibilità.
Connessi sempre, consapevoli poco
Oltre la metà dei giovani italiani trascorre più di tre ore al giorno connessa, e il 14% supera le cinque. Il dato in sé potrebbe sembrare fisiologico in un’epoca digitale, ma incrociato con altri indicatori rivela molto di più: il 43% dei ragazzi riceve richiami dai familiari per l’uso eccessivo dei dispositivi, e solo il 22% riesce a disconnettersi senza provare ansia.
Il 93% utilizza lo smartphone come principale canale di accesso, confermando che l’esperienza digitale non è più legata a un luogo fisico (come una scrivania o un computer), ma a una condizione costante, portatile, intima.
È qui che nasce quella che gli psicologi chiamano iperconnessione identitaria: il sé digitale diventa prolungamento del sé reale. Ogni notifica, ogni interazione, ogni visualizzazione diventa una micro–validazione del proprio valore. “Visibilità, follower e interazioni digitali sembrano diventare il metro del proprio valore personale”, osserva Antonio Affinita, direttore generale del Moige. “In nome di questa popolarità, spesso i ragazzi abbassano la guardia, correndo rischi che possono compromettere sicurezza e privacy.”
In questo scenario, il confine tra realtà e rappresentazione si assottiglia. La connessione prolungata non è più percepita come un eccesso, ma come una condizione necessaria per esistere.
Il problema, allora, non è il tempo trascorso online, ma la perdita di senso di quel tempo. Se ogni ora spesa davanti allo schermo sostituisce un’esperienza vissuta, la vita digitale smette di essere uno strumento e diventa un habitat emozionale.
Gli adulti leggono il fenomeno come “tempo rubato alla realtà”, ma per gli adolescenti la realtà stessa ha cambiato coordinate. L’online non è più il contrario dell’offline: è la scena principale dove si costruisce identità, appartenenza e riconoscimento. È una generazione che “c’è” solo se qualcuno la guarda.
La piazza dei social
Il 94% dei ragazzi frequenta regolarmente i social network: WhatsApp domina (87%), seguito da TikTok (58%), Instagram (57%) e YouTube (55%). Ma l’uso non è uniforme: il 64% si dichiara molto o abbastanza attivo, e il 63% usa la propria identità reale.
Solo il 17% crea contenuti originali; la maggioranza reagisce, commenta, condivide. È una socialità più reattiva che creativa, dove l’importante è esserci, non necessariamente dire qualcosa.
Il 91% afferma di avere più amici reali che virtuali, eppure il legame tra le due sfere è stretto: il 30% accetta richieste di sconosciuti, il 23% ha incontrato offline persone conosciute solo online.
È una soglia pericolosa, perché dietro la fiducia nella familiarità digitale si nasconde una vulnerabilità relazionale: quella di chi confonde l’attenzione per affetto, l’engagement per stima, il like per consenso.
La gestione della privacy resta superficiale: solo il 47% discute le impostazioni di sicurezza con un adulto, e circa la metà ha attivato filtri per contenuti inappropriati.
Il 49% ritiene che le piattaforme non proteggano adeguatamente i minori, ma la percezione del rischio resta bassa. L’educazione digitale non è interiorizzata come competenza di vita, ma trattata come una materia extracurricolare, spesso delegata alla scuola o ai genitori.
Il Moige, nel suo progetto “Educyber Generations”, parla di “ecosistema affettivo digitale”, un ambiente in cui emozioni e riconoscimento si sviluppano attraverso l’interazione algoritmica.
In questo contesto, anche la violenza si digitalizza. Il 7% dei ragazzi dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo, e il 16% testimone diretto.
Il 29% ha subito o assistito a insulti, esclusioni o pettegolezzi online, mentre un ulteriore 36% li considera “occasionali”. Solo il 5% segnala gli episodi a un adulto, e appena il 12% interviene in difesa della vittima.
Il silenzio è la norma, non l’eccezione. Non per mancanza di informazione: il 73% conosce le conseguenze legali del cyberbullismo, ma prevale la convinzione che “non serva a nulla” denunciare.
“La tecnologia amplifica ciò che trova: se manca empatia, amplifica il vuoto”, sintetizza Veronica Nicotra, segretario generale Anci.
La piazza digitale è dunque un’arena affollata ma fragile, dove la visibilità è potere e l’indifferenza è la punizione più comune.
L’Ai come scorciatoia
Il vero spartiacque del 2025, tuttavia, non è la connessione ma l’intelligenza artificiale.
Il 51% dei ragazzi la utilizza regolarmente, e la percentuale sale al 71% tra gli studenti delle superiori.
Il 29% la usa “sempre o spesso” per fare i compiti, percentuale che raddoppia (54%) nella fascia 15–17 anni.
Eppure solo il 21% ha ricevuto una formazione adeguata sui rischi e le opportunità dell’Ai, mentre un terzo dichiara di aver ricevuto risposte errate dagli strumenti.
È il dato più originale e preoccupante del rapporto: un uso massiccio ma inconsapevole dell’intelligenza artificiale, che rischia di sostituire il pensiero critico con la rapidità della risposta.
La nuova dipendenza non è più solo dalla connessione, ma dal calcolo.
Per la prima volta, i giovani non si limitano a usare uno strumento: si affidano a un interlocutore invisibile, capace di scrivere, decidere, scegliere al posto loro.
“È un digital divide cognitivo”, spiegano i ricercatori dell’Istituto Piepoli: non separa più adulti e giovani, ma distingue chi comprende dai semplici utilizzatori.
La maggioranza dei ragazzi non possiede gli strumenti per distinguere una risposta generata da un’informazione verificata, né per riconoscere bias e distorsioni algoritmiche.
Il rischio, secondo il Moige, è la nascita di una “coscienza delegata”, dove la capacità di pensare si appiattisce su ciò che l’Ai propone.
L’indagine mostra che il 48% dei giovani è già caduto in fake news, e che solo la metà verifica sempre le notizie online.
Il 70% afferma di saper riconoscere i deepfake, ma senza basi tecniche reali.
Siamo davanti a una generazione che vive dentro il digitale come in un linguaggio madre, ma senza grammatica. Usano ChatGPT o altri assistenti per risolvere esercizi, scrivere testi, riassumere libri — non come supporto, ma come sostituto.
Il problema non è la tecnologia, ma la deresponsabilizzazione cognitiva che produce: più l’Ai si fa “umana”, più l’umano smette di chiedersi come funziona.
Secondo Antonio Affinita, “l’uso crescente dell’intelligenza artificiale anche a scopi scolastici, ma senza consapevolezza, rappresenta una nuova forma di rischio. Non basta proibire: serve educare, accompagnare, rendere trasparenti gli strumenti”.
Ma oggi, circa un ragazzo su cinque riceve a scuola un’educazione digitale strutturata.
La “Generazione Ai” è tra i banchi, ma la scuola italiana non se ne è accorta
Il resto impara per imitazione, o per tentativi — e spesso l’apprendimento avviene direttamente dagli algoritmi.
In questo senso, la scuola rischia di perdere la sua funzione di mediazione tra sapere e realtà.
L’Ai non sostituisce il docente, ma lo mette alla prova: come educare alla verità in un’epoca in cui tutto è verosimile?
Dall’allarme educativo all’azione legale
L’altra grande novità del 2025 è che il Moige ha smesso di limitarsi all’allarme: ha deciso di portare le piattaforme in tribunale.
Il Movimento Italiano Genitori, insieme allo studio legale Ambrosio & Commodo, ha depositato presso il Tribunale di Milano la prima class action inibitoria italiana contro Meta e TikTok.
È un’azione pionieristica, fondata sull’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, che consente di chiedere l’ordine di cessazione o divieto di pratiche lesive verso una pluralità di soggetti.
L’udienza è fissata per il 12 febbraio 2026.
Le richieste sono tre:
- il rispetto dell’obbligo di verifica dell’età e il divieto di accesso ai social per i minori di 14 anni;
- l’eliminazione dei meccanismi di dipendenza basati su scroll infinito e algoritmi persuasivi;
- l’obbligo di informazione chiara e diffusa sui rischi dell’abuso delle piattaforme.
Il ricorso è accompagnato da un parere pro veritate del professor Tonino Cantelmi, docente di cyberpsicologia all’Università Europea di Roma, che parla di “rischio di danni cerebrali permanenti” dovuti alla stimolazione dopaminica continua prodotta dai social.
Un recente studio pubblicato su JAMA Pediatrics (giugno 2025, Maza et al.) conferma l’associazione tra uso compulsivo dei social e alterazioni funzionali nella corteccia prefrontale, l’area che regola l’autocontrollo e la capacità di giudizio.
“Le piattaforme non si limitano a ospitare contenuti: li progettano per essere irresistibili”, sottolinea l’avvocato Stefano Commodo, che guida il team legale. “La dipendenza digitale è l’effetto di un design comportamentale consapevole, costruito per trattenere gli utenti, non per informarli.”
Nelle 120 pagine del ricorso, viene ricostruito il modo in cui Meta e TikTok profilano gli utenti minorenni, raccolgono dati di navigazione e durata dei contenuti, e li utilizzano per ottimizzare la permanenza in piattaforma.
L’obiettivo non è solo ottenere un provvedimento inibitorio, ma creare un precedente giuridico europeo che obblighi le big tech a rendere trasparenti i loro algoritmi di raccomandazione.
“Purtroppo la protezione dei minori non solo non viene perseguita adeguatamente, ma viene danneggiata da algoritmi che creano disagio e dipendenza”, ha dichiarato Affinita.
Pochi giorni dopo, la Lega ha presentato un disegno di legge per vietare l’uso dei social agli under 14.
Il Moige ha accolto con favore l’iniziativa, pur chiedendo “una riforma più ampia, capace di chiarire anche le responsabilità dei danni arrecati o subiti dai minori”.
In un paese dove Meta e TikTok contano complessivamente circa 90 milioni di utenze attive — più della popolazione nazionale — la questione non è marginale.
La sfida è stabilire chi protegge chi: se siano le piattaforme a dover vigilare sui minori, o le istituzioni a dover vigilare sulle piattaforme.
Il rischio, ancora una volta, è che nel frattempo i ragazzi continuino a vivere in un ecosistema che li osserva più di quanto essi comprendano di essere osservati.
La Gen Z si rivolge a ChatGpt per risolvere i problemi di cuore
—
Giovani
content.lab@adnkronos.com (Redazione)